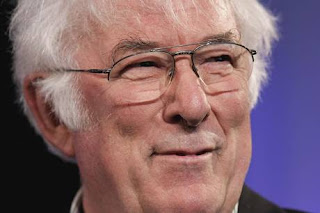A volte, si fatica a comprendere con quale criterio i media scelgano le notizie da mettere in risalto. Si è parlato per settimane intere, fino alla nausea, dello spionaggio americano (e britannico) a danno dei paesi occidentali alleati e amici. Dalla Francia si sono levate voci irritate e offese; la Germania ha convocato gli ambasciatori USA e GB, e paventato di rivedere gli accordi commerciali tra Europa e Stati Uniti. Grande preoccupazione anche in Italia: la nostra privacy sarebbe a forte rischio, a causa di queste intercettazioni illegali. Eppure, anche i bambini sanno che una delle principali attività dei servizi segreti di ogni paese è spiare, e che da che mondo è mondo tutti spiano tutti. Quindi, non si sa se stupirsi più per le reazioni di certe cancellerie, o per l’enfasi data dai media a certe “non notizie”. Soprattutto se confrontiamo questa enfasi con il fatto che altri, ben più significativi avvenimenti, passano quasi inosservati. Ci riferiamo in modo particolare al comportamento recente di un attore non certo irrilevante sulla scena internazionale: l’Arabia Saudita.
Il regno dei Saud ha rinunciato, con una scelta finora senza precedenti, a occupare uno dei 10 seggi a rotazione nel Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Normalmente, c’è grande competizione tra i vari paesi per avere il privilegio e l’opportunità di sedersi, per due anni, allo stesso tavolo dei 5 membri permanenti (USA, Gran Bretagna, Russia, Cina e Francia) per discutere le “issues” di più grande rilevanza per la sicurezza internazionale. Ebbene l’Arabia Saudita non soltanto ha rinunciato al seggio, ma ha anche pesantemente criticato le Nazioni Unite, accusandole di comportarsi secondo standard molto diversi a seconda delle questioni sul tappeto e asserendo che una riforma dell’ONU sia ormai improcrastinabile. “Work mechanisms and double-standards on the Security Council prevent it from carrying out its duties and assuming its responsibilities in keeping world peace”, ha affermato in una nota il Ministero degli Esteri saudita. ”Therefore Saudi Arabia... has no other option but to turn down Security Council membership until it is reformed […]”. In modo specifico, i sauditi hanno accusato la comunità internazionale di aver fallito nel caso del conflitto in Siria, avendo tra l’altro consentito al regime di Assad di massacrare la propria popolazione tramite le armi chimiche senza imporre alcuna sanzione o alcun deterrente; di non essere riuscita a trovare ancora una soluzione alla questione palestinese che si trascina da 65 anni; e di non essere riuscita nemmeno a evitare la proliferazione di armamenti, anche nucleari, in Medio Oriente.
Questa notizia fa il paio con un’altra, ben più allarmante: l’Arabia Saudita sarebbe pronta a ricevere dal Pakistan armi atomiche. I sauditi hanno infatti copiosamente finanziato il programma nucleare pakistano: si tratterebbe “solo” di farsi consegnare le armi dall’unico paese islamico finora dotato di bomba atomica. La notizia arriva dalla BBC, che cita fonti di intelligence NATO nonché l’ex capo dell’intelligence militare di Israele, Amos Yadlin. Yadlin afferma che, se l’Iran si doterà di armi nucleari, i sauditi non aspetteranno neanche un mese: poiché hanno già pagato per la loro bomba, semplicemente andranno in Pakistan a prendere ciò di cui hanno bisogno (“the Saudis will not wait one month. They already paid for the bomb, they will go to Pakistan and bring what they need to bring”). Ed è impossibile non tornare con la memoria al luglio scorso, quando la stampa britannica rese pubbliche alcune immagini satellitari secondo cui nella base saudita di Al-Watah, circa 125 miglia a sud-ovest di Riyadh, sarebbero state completate rampe di lancio per missili balistici (DF3 di produzione cinese, con portata di 1.500–2.500 miglia) con obiettivi Israele e l’Iran. Secondo esperti dell’IHS Jane’s Intelligence Review (una società di intelligence privata specializzata in sicurezza militare e nazionale) i sauditi starebbero aggiornando i missili per renderli più precisi e, soprattutto, in grado di trasportare testate nucleari. L’Arabia Saudita è in possesso, si ritiene, anche di missili CSS-2.
Questo spiegamento di muscoli da parte di Riyadh ha evidentemente due destinatari principali. Il primo, ovviamente, è l’Iran: i sauditi vogliono far sapere al regime degli ayatollah, loro nemico storico, che non gli permetteranno certo di poter diventare, grazie all’arma atomica, la superpotenza regionale in grado di dettare legge nell’intero Medio Oriente. Anzi, l’influenza iraniana sull’Iraq, in Siria e, tramite Hezbollah, in Libano è già assai dura da digerire per il regno dei Saud. L’accelerazione di Riyadh può anche essere letta come l’aver raggiunto il convincimento che i negoziati tra Stati Uniti, Russia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Iran non porteranno a nulla di buono. Nel senso che, probabilmente, non riusciranno a fermare il programma nucleare di Teheran, ormai non così lontano dal successo. Posizione nella sostanza condivisa da Israele: Netanyahu ha più volte pubblicamente affermato che l’accordo che andava profilandosi prima della sospensione dei colloqui era pessimo e pericoloso, dato che lascerebbe intatte le capacità di arricchimento nucleare degli ayatollah.
Il secondo destinatario dei messaggi sauditi è, invece, l’America. Con la quale le relazioni si sono raffreddate, poiché ci sono molti punti in agenda sui quali Riyadh si trova su posizioni diverse da Washington. In primis la Siria: i sauditi vorrebbero Assad fuori dai giochi, e conseguentemente la diminuzione dell’influenza iraniana sul paese. L’Arabia Saudita non cela la sua frustrazione per i mancati progressi sul campo, nonché per il rifiuto degli USA di un attacco militare (seppur limitato) contro l’esercito regolare siriano. In secondo luogo, i sauditi sono rimasti molto sorpresi di quanto velocemente, nel 2011, gli USA abbiano “abbandonato” Mubarak e, con lui, un regime ad essi alleato per decenni. Più che ovvio che si siano chiesti “Farebbero lo stesso con noi, nell’eventualità di una rivolta simile a Riyadh?”. In terzo luogo, vi è un aspetto a lungo termine ma non meno significativo. I sauditi sono ben consci del fatto che gli USA diventeranno, nei prossimi decenni, autosufficienti nella produzione di energia grazie allo “shale oil” (idrocarburi estratti dalle rocce con tecniche di frantumazione). Questo porterà inevitabilmente a una diminuzione di interesse strategico per l’area del Golfo; se a questo aggiungiamo la tanto reclamizzata nuova politica estera USA, basata sul “pivot to Asia”, comprendiamo come i sauditi possano guardare con una certa preoccupazione a un futuro nel quale la presenza militare dell’alleato americano nell’area non sarà più così massiccia.
A tutto vantaggio dell’Iran. E qui arriviamo al quarto e, al momento, più importante motivo di contrasto tra Riyadh e Washington. Sin dalla rivoluzione khomeinista del 1979, le relazioni tra i sauditi e l’Iran sono improntate a un confronto serrato e senza esclusione di colpi per il ruolo di potenza dominante in Medio Oriente. È un conflitto che ha, per ora, un campo di battaglia concreto sul suolo siriano: le due potenze sostengono apertamente gli schieramenti rivali (l’Iran fornisce armi e combattenti al regime di Assad, l’Arabia garantisce imponenti finanziamenti e forniture di armi ai ribelli). I sauditi sono talmente nemici di Teheran (non si dimentichi la combinazione di fattori etnico-religiosi: arabi sunniti contro persiani sciiti) da far fronte comune anche con l’odiato Israele in funzione anti-iraniana. Sebbene ufficialmente l’Arabia Saudita non riconosca lo Stato ebraico e non abbia con esso relazioni diplomatiche ufficiali, dietro le quinte i due paesi mantengono aperto un canale di comunicazione come strumento volto a promuovere la stabilità della regione. Stabilità messa seriamente a rischio dall’Iran, direttamente con il programma nucleare, e indirettamente tramite il sostegno alle popolazioni sciite in Iraq, Bahrein, nello Yemen, e il supporto a Hezbollah.
Nessuno di questi punti di disaccordo darà luogo alla fine dell’alleanza tra USA e Arabia Saudita. Almeno, non nel breve periodo. Certo è che tutti questi sommovimenti fanno capire la vera natura della posta in gioco: i futuri assetti geopolitici nell’area del Golfo. I sauditi sanno che gli americani hanno un disperato bisogno di qualche successo diplomatico nell’area (molto difficile il negoziato israelo-palestinese, qualche spiraglio in più potrebbe aprirsi con l’Iran); sono perciò sicuramente disposti a tollerare qualche concessione agli ayatollah da parte del loro alleato. Ma Riyadh sa anche che il Medio Oriente è ancora troppo importante per gli USA perché questi possano allentare troppo la pressione sull’Iran: di sicuro, non tollereranno un’egemonia militare di Teheran che possa aggiungersi alla marcata influenza iraniana sulle molte minoranze sciite diffuse in tutta la regione. Nonostante il supporto americano, però, è chiaro che i sauditi hanno avvertito la necessità muoversi più attivamente anche in prima persona. Il futuro assetto geopolitico nel Golfo dipende da come gli attori si comportano oggi: Riyadh non ha fatto altro che muovere alcune delle sue pedine, in modo da non dover dipendere troppo dal suo alleato storico.
Rimane però sospesa un’altra questione. Era prevedibile che l’aver consentito all’Iran di sviluppare il suo programma nucleare sino a questo punto avrebbe determinato una corsa agli armamenti atomici in tutto il Medio Oriente. È dunque egualmente prevedibile che le potenze nucleari esistenti siano interessate a vendere la loro tecnologia ai potenziali acquirenti. Con tempestività invidiabile, giovedì scorso una delegazione di alti funzionari russi si è recata in visita al Cairo, con la prospettiva di firmare un accordo per forniture militari del valore di 2 miliardi di dollari. Tra una riunione a l’altra, che si sia trovato il tempo di sondare il terreno in merito? Forse sì, forse no; ma sarebbe da sciocchi pensare che Putin, in questo scenario così fluido, non abbia fiutato la possibilità di un inserimento in grande stile dell’orso russo nell’area…
Fonti:
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-24580767
http://www.israele.net/sauditi-pronti-a-ricevere-dal-pakistan-le-atomiche-di-cui-hanno-finanziato-la-produzione
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-24823846
http://www.rightsreporter.org/missili-sauditi-puntati-su-israele/
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/saudiarabia/10172463/Saudi-Arabia-targeting-Iran-and-Israel-with-ballistic-missiles.html
http://www.janes.com/article/24321/saudi-ballistic-missile-site-revealed
http://www.stratfor.com/sample/analysis/reality-reported-saudi-pakistani-nuclear-cooperation
http://www.formiche.net/2013/11/11/ecco-i-veri-motivi-del-negoziato-usa-iran/
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-24944325
Il regno dei Saud ha rinunciato, con una scelta finora senza precedenti, a occupare uno dei 10 seggi a rotazione nel Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Normalmente, c’è grande competizione tra i vari paesi per avere il privilegio e l’opportunità di sedersi, per due anni, allo stesso tavolo dei 5 membri permanenti (USA, Gran Bretagna, Russia, Cina e Francia) per discutere le “issues” di più grande rilevanza per la sicurezza internazionale. Ebbene l’Arabia Saudita non soltanto ha rinunciato al seggio, ma ha anche pesantemente criticato le Nazioni Unite, accusandole di comportarsi secondo standard molto diversi a seconda delle questioni sul tappeto e asserendo che una riforma dell’ONU sia ormai improcrastinabile. “Work mechanisms and double-standards on the Security Council prevent it from carrying out its duties and assuming its responsibilities in keeping world peace”, ha affermato in una nota il Ministero degli Esteri saudita. ”Therefore Saudi Arabia... has no other option but to turn down Security Council membership until it is reformed […]”. In modo specifico, i sauditi hanno accusato la comunità internazionale di aver fallito nel caso del conflitto in Siria, avendo tra l’altro consentito al regime di Assad di massacrare la propria popolazione tramite le armi chimiche senza imporre alcuna sanzione o alcun deterrente; di non essere riuscita a trovare ancora una soluzione alla questione palestinese che si trascina da 65 anni; e di non essere riuscita nemmeno a evitare la proliferazione di armamenti, anche nucleari, in Medio Oriente.
Questa notizia fa il paio con un’altra, ben più allarmante: l’Arabia Saudita sarebbe pronta a ricevere dal Pakistan armi atomiche. I sauditi hanno infatti copiosamente finanziato il programma nucleare pakistano: si tratterebbe “solo” di farsi consegnare le armi dall’unico paese islamico finora dotato di bomba atomica. La notizia arriva dalla BBC, che cita fonti di intelligence NATO nonché l’ex capo dell’intelligence militare di Israele, Amos Yadlin. Yadlin afferma che, se l’Iran si doterà di armi nucleari, i sauditi non aspetteranno neanche un mese: poiché hanno già pagato per la loro bomba, semplicemente andranno in Pakistan a prendere ciò di cui hanno bisogno (“the Saudis will not wait one month. They already paid for the bomb, they will go to Pakistan and bring what they need to bring”). Ed è impossibile non tornare con la memoria al luglio scorso, quando la stampa britannica rese pubbliche alcune immagini satellitari secondo cui nella base saudita di Al-Watah, circa 125 miglia a sud-ovest di Riyadh, sarebbero state completate rampe di lancio per missili balistici (DF3 di produzione cinese, con portata di 1.500–2.500 miglia) con obiettivi Israele e l’Iran. Secondo esperti dell’IHS Jane’s Intelligence Review (una società di intelligence privata specializzata in sicurezza militare e nazionale) i sauditi starebbero aggiornando i missili per renderli più precisi e, soprattutto, in grado di trasportare testate nucleari. L’Arabia Saudita è in possesso, si ritiene, anche di missili CSS-2.
Questo spiegamento di muscoli da parte di Riyadh ha evidentemente due destinatari principali. Il primo, ovviamente, è l’Iran: i sauditi vogliono far sapere al regime degli ayatollah, loro nemico storico, che non gli permetteranno certo di poter diventare, grazie all’arma atomica, la superpotenza regionale in grado di dettare legge nell’intero Medio Oriente. Anzi, l’influenza iraniana sull’Iraq, in Siria e, tramite Hezbollah, in Libano è già assai dura da digerire per il regno dei Saud. L’accelerazione di Riyadh può anche essere letta come l’aver raggiunto il convincimento che i negoziati tra Stati Uniti, Russia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Iran non porteranno a nulla di buono. Nel senso che, probabilmente, non riusciranno a fermare il programma nucleare di Teheran, ormai non così lontano dal successo. Posizione nella sostanza condivisa da Israele: Netanyahu ha più volte pubblicamente affermato che l’accordo che andava profilandosi prima della sospensione dei colloqui era pessimo e pericoloso, dato che lascerebbe intatte le capacità di arricchimento nucleare degli ayatollah.
Il secondo destinatario dei messaggi sauditi è, invece, l’America. Con la quale le relazioni si sono raffreddate, poiché ci sono molti punti in agenda sui quali Riyadh si trova su posizioni diverse da Washington. In primis la Siria: i sauditi vorrebbero Assad fuori dai giochi, e conseguentemente la diminuzione dell’influenza iraniana sul paese. L’Arabia Saudita non cela la sua frustrazione per i mancati progressi sul campo, nonché per il rifiuto degli USA di un attacco militare (seppur limitato) contro l’esercito regolare siriano. In secondo luogo, i sauditi sono rimasti molto sorpresi di quanto velocemente, nel 2011, gli USA abbiano “abbandonato” Mubarak e, con lui, un regime ad essi alleato per decenni. Più che ovvio che si siano chiesti “Farebbero lo stesso con noi, nell’eventualità di una rivolta simile a Riyadh?”. In terzo luogo, vi è un aspetto a lungo termine ma non meno significativo. I sauditi sono ben consci del fatto che gli USA diventeranno, nei prossimi decenni, autosufficienti nella produzione di energia grazie allo “shale oil” (idrocarburi estratti dalle rocce con tecniche di frantumazione). Questo porterà inevitabilmente a una diminuzione di interesse strategico per l’area del Golfo; se a questo aggiungiamo la tanto reclamizzata nuova politica estera USA, basata sul “pivot to Asia”, comprendiamo come i sauditi possano guardare con una certa preoccupazione a un futuro nel quale la presenza militare dell’alleato americano nell’area non sarà più così massiccia.
A tutto vantaggio dell’Iran. E qui arriviamo al quarto e, al momento, più importante motivo di contrasto tra Riyadh e Washington. Sin dalla rivoluzione khomeinista del 1979, le relazioni tra i sauditi e l’Iran sono improntate a un confronto serrato e senza esclusione di colpi per il ruolo di potenza dominante in Medio Oriente. È un conflitto che ha, per ora, un campo di battaglia concreto sul suolo siriano: le due potenze sostengono apertamente gli schieramenti rivali (l’Iran fornisce armi e combattenti al regime di Assad, l’Arabia garantisce imponenti finanziamenti e forniture di armi ai ribelli). I sauditi sono talmente nemici di Teheran (non si dimentichi la combinazione di fattori etnico-religiosi: arabi sunniti contro persiani sciiti) da far fronte comune anche con l’odiato Israele in funzione anti-iraniana. Sebbene ufficialmente l’Arabia Saudita non riconosca lo Stato ebraico e non abbia con esso relazioni diplomatiche ufficiali, dietro le quinte i due paesi mantengono aperto un canale di comunicazione come strumento volto a promuovere la stabilità della regione. Stabilità messa seriamente a rischio dall’Iran, direttamente con il programma nucleare, e indirettamente tramite il sostegno alle popolazioni sciite in Iraq, Bahrein, nello Yemen, e il supporto a Hezbollah.
Nessuno di questi punti di disaccordo darà luogo alla fine dell’alleanza tra USA e Arabia Saudita. Almeno, non nel breve periodo. Certo è che tutti questi sommovimenti fanno capire la vera natura della posta in gioco: i futuri assetti geopolitici nell’area del Golfo. I sauditi sanno che gli americani hanno un disperato bisogno di qualche successo diplomatico nell’area (molto difficile il negoziato israelo-palestinese, qualche spiraglio in più potrebbe aprirsi con l’Iran); sono perciò sicuramente disposti a tollerare qualche concessione agli ayatollah da parte del loro alleato. Ma Riyadh sa anche che il Medio Oriente è ancora troppo importante per gli USA perché questi possano allentare troppo la pressione sull’Iran: di sicuro, non tollereranno un’egemonia militare di Teheran che possa aggiungersi alla marcata influenza iraniana sulle molte minoranze sciite diffuse in tutta la regione. Nonostante il supporto americano, però, è chiaro che i sauditi hanno avvertito la necessità muoversi più attivamente anche in prima persona. Il futuro assetto geopolitico nel Golfo dipende da come gli attori si comportano oggi: Riyadh non ha fatto altro che muovere alcune delle sue pedine, in modo da non dover dipendere troppo dal suo alleato storico.
Rimane però sospesa un’altra questione. Era prevedibile che l’aver consentito all’Iran di sviluppare il suo programma nucleare sino a questo punto avrebbe determinato una corsa agli armamenti atomici in tutto il Medio Oriente. È dunque egualmente prevedibile che le potenze nucleari esistenti siano interessate a vendere la loro tecnologia ai potenziali acquirenti. Con tempestività invidiabile, giovedì scorso una delegazione di alti funzionari russi si è recata in visita al Cairo, con la prospettiva di firmare un accordo per forniture militari del valore di 2 miliardi di dollari. Tra una riunione a l’altra, che si sia trovato il tempo di sondare il terreno in merito? Forse sì, forse no; ma sarebbe da sciocchi pensare che Putin, in questo scenario così fluido, non abbia fiutato la possibilità di un inserimento in grande stile dell’orso russo nell’area…
Fonti:
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-24580767
http://www.israele.net/sauditi-pronti-a-ricevere-dal-pakistan-le-atomiche-di-cui-hanno-finanziato-la-produzione
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-24823846
http://www.rightsreporter.org/missili-sauditi-puntati-su-israele/
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/saudiarabia/10172463/Saudi-Arabia-targeting-Iran-and-Israel-with-ballistic-missiles.html
http://www.janes.com/article/24321/saudi-ballistic-missile-site-revealed
http://www.stratfor.com/sample/analysis/reality-reported-saudi-pakistani-nuclear-cooperation
http://www.formiche.net/2013/11/11/ecco-i-veri-motivi-del-negoziato-usa-iran/
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-24944325